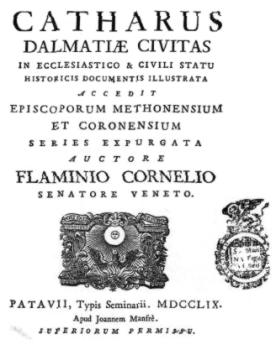CAPITOLO TERZO
LA QUESTIONE DELLE DUE CĄTTARO
1. Ipotesi e considerazioni sulla presunta esistenza della Cąttaro pugliese
Forse č tutta colpa di quella leggenda locale raccolta circa due secoli fa dal Mola, se ora siam qui a discutere se in Terra di Bari (l'antica Peucetia) e in particolare nel territorio nojano sia veramente esistita una cittą di nome Cąttaro, di cui finora mancano prove certe che ne attestino con rigore storico-archeologico e l'esistenza e il sito. A parlarne č solo la tradizione orale nojana, secondo la quale, dopo la fondazione di Noja nell'entroterra pił vicino da parte di alcuni gruppi di sopravvissuti di Cąttaro, altri avrebbero preferito raggiungere l'opposta sponda adriatica per dar vita in un luogo pił tranquillo, nella Dalmazia meridionale. ad un nuovo centro urbano che, in ricordo di quello lasciato in patria, misteriosamente scomparso o distrutto dalle orde barbariche, avrebbero chiamato ugualmente Cąttaro, che corrisponde all'odierna Kņtor, una delle cittą pił belle della Repubblica del Montenegro, ricca di storia e di monumenti antichi. Ma in nessuna delle numerose leggende sulle origini storiche di questa cittą slava vi č il pur minimo accenno al racconto popolare nojano[1]. Esistono, purtroppo, diverse prove inconfutabili tendenti a screditare il racconto leggendario nojano e tutti i reiterati tentativi degli scrittori locali alla ricerca di riscontri storici e archeologici per riabilitare e far tornare in vita, come l'Araba Fenice che risorge dalle sue ceneri, il fantomatico centro peucetico di Cąttaro.
Qualcuno, infatti, stando alle parole della leggenda, avrebbe individuato il sito della vetusta cittą costiera nei ruderi marini appena visibili di cala Paduano, a sud di Torre a Mare, verso Mola di Bari, nel cui territorio amministrativo quelli sono attualmente ubicati [2] . E poi c'č da chiedersi donde il Roppo ed il Tagarelli abbiano tirato fuori i termini di Katri, Katry, Kattri, Kattry, con i quali, forse, avranno voluto far primeggiare e distinguere da quella dalmata la Cąttaro peucetica, quando a riguardo non esiste alcuna fonte scritta. E questo perché i due Autori hanno collocato l'arcaico centro nella storia non scritta, cioč nella preistoria, non potendo fare altrimenti. Inoltre, se la definitiva scomparsa di detto centro costiero, ritenuto molto importante, viene stabilita, secondo la tradizione locale, nell'VIII - IX sec. d. C., come č possibile che esso non sia stato mai notato o individuato'all' epoca della costruzione della "Consolare Traiana" nel II secolo d. C., che toccava tutti i grandi centri costieri della provincia di Bari? Dunque, l'arduo tentativo di dare a tutti i costi un fondamento storico alla leggenda, da parte di alcuni studiosi di casa nostra, non ha fatto altro che provocare una serie di equivoci e di contraddizioni, dovuti soprattutto, nel nostro caso, alla scarsa conoscenza della ricca tradizione storica. geografica ed economica della Cąttaro dąlmata. Esaminandola bene, infatti, ci accorgiamo di quanto si dimostrino inconsistenti le ipotesi sui presunti rapporti storici e cultuli tra la fantomatica cittą marittima pugliese, su cui la Storia ufficiale tace, e l'attivo, omonimo centro slavo, ricco di monumenti [3] antichi e di storia Della storia e delle tradizioni culturali di quest'ultimo, particolarmente delle sue vicende ecclesiastiche (la cittą č antica sede vescovile), infatti, si sono interessati diversi scrittori veneziani del Settecento [4], che ci hanno lasciato un gran numero di notizie interessanti. Non ci resta, quindi, che esaminarle e confrontarle con quelle provenienti dalla tradizione leggendaria intorno alla Cąttaro pugliese, di cui ci si ostina a dimostrare l'esistenza; tanto č vero che il Roppo, dando per scontato che il racconto leggendario nojano non poteva scostarsi tanto dalla realtą, confortato dalle teorie degli archeologi Mola e Gervasio, cerca di giustificarne in qualche modo le cause della scomparsa, ritenendo che i responsabili della sua distruzione (pur nutrendo qualche dubbio sulla sua ubicazione) possano essere stati il bradisismo e l'erosione marina [5]. Per il Tagarelli, invece, assolutamente convinto che il preistorico Katry sia vissuto nella cala Paduano, le cause della sua inesorabile sparizione sarebbero dovute alle continue guerre e distruzio ni, che avrebbero determinato la fuga di molti suoi abitanti nell'immediato entroterra, dove fondarono Noja, e di tanti altri verso le famose Bocche del golfo dalmata, «accolti nel pił sicuro e prosperoso rifugio di una patria slava, se non di origine, diventata sicuramente di elezione» [ 6].
L' archeologia, purtroppo, non dą ragione al Tagarellķ [7] il quale, per non vedere vacillare la sua tesi, colloca il Kattry nella preistona, ed il gioco č fatto. E, per dirla con Dante Alighieri: «Cosa fatta capo ha». Piuttosto, avremmo preferito che la leggenda nojana ci avesse raccontato pił ampiamente della nascita di Noja, pił che indugiare su un toponimo, Cąttaro, di cui si ignora completamente l'esistenza in Terra di Bari sia dal punto di vista letterario che storico e archeologico; non certo dell'omonima, blasonata cittą dalmata. A pensarci bene, il Mola, nel riferire la leggenda nojana, non parla affatto di "fondazione" di Noja da parte dei sopravvissuti della vicina Cąttaro peucetica, ma soltanto di "esistenza" di questa nei suoi dintorni, mentre alcuni di essi, forse, dopo la sua distruzione avrebbero raggiunto le coste della Dalmazia sulla sponda opposta per fondare una cittą di ugual nome. Ma quando e in che modo tutto questo sarebbe avvenuto, il racconto popolare non ce lo dice.
Note
[1] Lo scrittore veneziano Flaminio CORNELIO, nelle pagine introduttive alla sua opera Catharus Dalmatiae Civitas (Padova, Manfrč 1759), riporta un lungo elenco di ipotesi e di leggende sulle origini storiche di Cątharum (Cąttaro) in Dalmazia, ma nessuna di esse parla di un possibile coinvolgimento di profughi provenienti dalla omonima cittą pugliese. Pertanto, se avesse saputo o trovato qualcosa, egli avrebbe certamente inserito tra quelle anche la leggenda nojana.
[2] L'estrema vicinanza dell'arcaico sito di Paduano all'attuale centro abitato di Noicąttaro ha convinto definitivamente il Tagarelli che proprio lģ, in quella cala naturale, doveva essere esistita l'antichissima Cąttaro peucetica (Cfr. S. Tagarelli, Il mio paese, III,., pp. 34 - 37). Inoltre, una prova tangibile che Noja sarebbe stata fondata da gente della vicina costa, e quindi anche da quella proveniente dal centro costiero di Cąttaro, č data, secondo l'A., dalla presenza di diverse famiglie di pescatori nella attuale comunitą di Noicąttaro (Cfr. S. TAGARELLI, Il mio paese, I, Bari, Milillo 1961, p. 6 e segg.).
[3] Il Roppo dice bene, quando consiglia: «A lumeggiare la storia di Cąttaro pugliese dovrebbe concorrere la storia comparativa di Cąttaro della Dalmazia», ma dimostra di essere scarsamente informato, quando conclude: «Ma anche questa tace» alludendo alla storia della Cąttaro dąlmata (Cfr. V. ROPPO, op. cit., p 86).
[4] Vogliamo ricordare che Cąttaro di Dalmazia č stata sotto il protettorato di Venezia dal 1421 al 1797 (Cfr. F. SFORZA, Bari e Kotor, Cassano, Ecumenica Editrice 1975, p. 167).
[5] La Cąttaro o Katri, di cui ci sfugge la precisa ubicazione, - dice precisamente il Roppo - se la leggenda di essa dovesse avere un riferimento storico probabile, ci fa supporre alla sua sparizione dei suoi ruderi ed avanzi ad opera dell'invasione del lido a causa del mare [....] che ad opera invece dell'invasione barbarica (V. ROPPO, op. cit.,p. 85)
[6] Cfr. S. TAGARELLI, Il mio paese, III op. cit., p. 35.
[7] Cfr. F. BIANCOFIORE, La Viabilitą a sud-est di Bari, in "Archivio Storico Pugliese", XVII, Bari,1964. Dello stesso A., si veda anche Torre a Mare: Scavo nell'abitato antico di Punta la Penna, Estratto dagli "Atti" dell'Accademia dei Lincei, Roma, 1976.